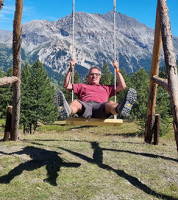
massimomassarenti
Assisi
La chiesa superiore presenta una facciata semplice a "capanna". La parte alta è decorata con un rosone centrale, con ai lati i simboli degli Evangelisti in rilievo. La parte bassa è arricchita dal maestoso portale strombato. Sul lato sinistro della facciata è stata appoggiata , nel Seicento, la Loggia delle benedizioni dalla quale, in epoca passata, si mostrava il Velo santo della Madonna. Sullo stesso lato, poco dopo la costruzione della chiesa superiore, è stato innalzato il campanile, un tempo cuspidato.
L'architettura interna mostra invece i caratteri più tipici del gotico italiano: archi a sesto acuto che attraversano la navata, poggianti su semipilastri a fascio, dai quali si diramano costolature delle volte a crociera ogivali e degli arconi laterali che incorniciano le finestre. La fascia inferiore è invece liscia, e venne predisposta fin dall'inizio per la creazione di una bibbia per i poveri, rappresentata dalla decorazione didascalica ad affresco. Rispetto ad esempi marcatamente schiacciati (come la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano) o ad altri orientati verso il verticalismo (gotico d'Oltralpe), la basilica francescana presenta un bilanciato equilibrio in alzato, con lo slancio dei pilastri e delle volte interrotto dall'orizzontalità del ballatoio che corre sotto le finestre, che dà un sofisticato ritmo di linee perpendicolari.
Una certa somiglianza viene evidenziata con alcuni edifici francesi, come la cattedrale di Angers, che presenta affinità sia in alzato sia in pianta.
La basilica superiore contiene la più completa raccolta di vetrate medievali d'Italia. Quelle della zona absidale (antecedenti al 1253) sono attribuite ad artisti della Germania nord-orientale, mentre quelle del transetto e della navata sono in parte di francesi e in parte di una bottega nata nell'ambito dell'officina del Maestro di San Francesco, databili nella seconda metà del XIII secolo.
Intorno al 1288 sarebbero iniziate anche le decorazioni ad affresco. La decorazione di entrambe le basiliche corrisponde ad una serie di programmi (in qualche caso, in parte, distrutti), ciascuno dei quali è stato pensato in vista di un piano decorativo integrale, finalizzato all'esaltazione della figura di san Francesco.
Lo straordinario risultato finale è dovuto al contributo essenziale di artisti di altissimo livello come Cimabue e Giotto, le cui sperimentazioni hanno fatto, della basilica di Assisi, uno dei luoghi più importanti per l'evoluzione dell'arte italiana ed europea tra il Duecento e il Trecento.
La basilica superiore è adibita alle funzioni liturgiche di carattere ufficiale, come testimonia la presenza del trono papale nell'abside.
La basilica superiore fu modello e ispirazione per le chiese francescane, anche se talvolta venne liberamente reinterpretato, per esempio usando una copertura a capriate invece delle volte. Tra le derivazioni più dirette la basilica di Santa Chiara, sempre ad Assisi, le chiese di san Francesco a Arezzo e a Cortona, la basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli. Fuori dall'Italia si riscontrano somiglianze per esempio nella Cattedrale di Angers in Francia, dove probabilmente ci furono contatti tramite Haymo di Faversham, generale dei francescani dal 1240 al 1244.
La basilica di San Francesco ad Assisi, è il luogo che dal 1230 conserva e custodisce le spoglie mortali del santo serafico. Voluta da papa Gregorio IX quale specialis ecclesia, venne insignita dallo stesso Pontefice del titolo di Caput et Mater dell'Ordine minoritico e contestualmente affidata in perpetuo agli stessi frati.
Nella complessa storia che ha segnato l'evoluzione dell'Ordine, la basilica (e l'annesso Sacro Convento) fu sempre custodita dai cosiddetti "frati della comunità", il gruppo che andò in seguito a costituire l'Ordine dei Frati Minori Conventuali.
Presso la Chiesa sepolcrale della Basilica dove fu eretto l'altare sulla tomba del Santo, il 19 novembre 1585, il papa francescano Sisto V, con la bolla Supernae dispositionis istituiva l'Arciconfraternita dei Cordigeri.
Nel 1754 Benedetto XIV l'ha elevata alla dignità di Basilica Patriarcale (oggi "Papale") e Cappella Papale. Nell'anno 2000, insieme ad altri siti francescani del circondario, la basilica è stata inserita nella Lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.














